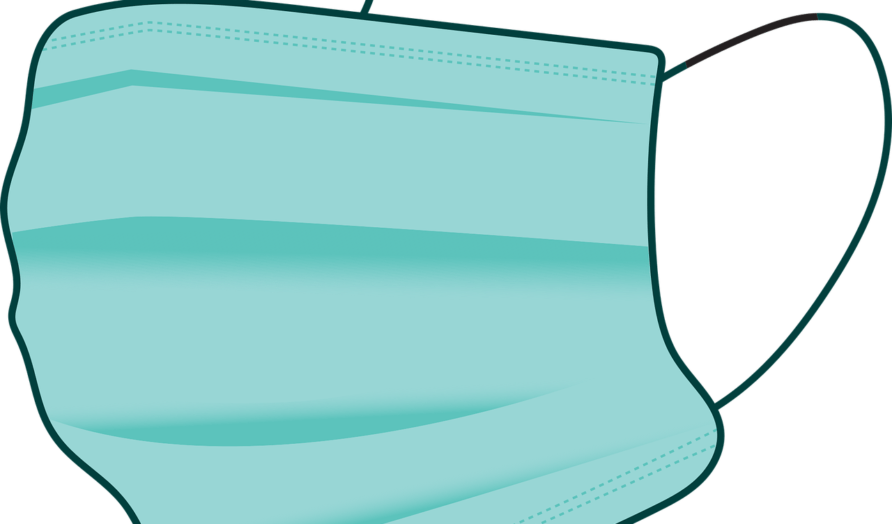Che cosa hanno in comune Myss Keta, Junior Cally e Billie Eilish? Il fatto di essere artisti e, in particolare, cantanti.
Vero, ma c’è dell’altro.
Pur con messaggi e stili completamente diversi, hanno innescato – in tempi non sospetti – la curiosità su quello che nel 2020 sarebbe diventato l’accessorio per eccellenza, il “must-have” (ahimè, nel senso letterale del termine): la mascher(in)a.
Era infatti il 26 gennaio 2020 quando, alla celebrazione dei Grammy Awards, la cantante di Los Angeles ne ha sfoggiata una firmata Gucci, in tulle nero e doppia “G” di cristalli. Ma la moda, si sa, è spesso antesignana dei trends ed oggi la pandemia ha creato un nuovo bisogno: la mascherina. Se griffata, tanto meglio. A tal punto che quella di Fendi, tra le prime, in vendita a 190,00 euro, è andata subito sold out. Richiestissime sono anche quelle con le “black wings” di Marcelo Burlon oppure quelle con il celeberrimo “monogram” di Louis Vuitton, rese ancora più desiderabili dalle foto postate sul proprio profilo Instagram da Chiara Ferragni.
Il fenomeno, come spesso accade, non è sfuggito ai contraffattori che – complice la pandemia – hanno deciso di inventarsi un nuovo business. Già nei primi giorni del mese scorso, a seguito di alcuni controlli volti ad accertare la sussistenza dei requisiti di varie imprese che, per rimanere aperte, hanno dichiarato di aver convertito la produzione in beni di necessità, le Fiamme Gialle del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Rimini hanno scoperto una serigrafia locale dedita alla stampa di “stencil” con i loghi dei più famose case stilistiche da applicare sul tessuto delle mascherine “così da trasformarle in ricercati accessori di moda”.
La denuncia è scattata ma appare indubbio che quanto rinvenuto rappresenti in realtà soltanto la punta dell’iceberg.
Ed allora, quali possono essere gli strumenti civilisti a tutela dei segni distintivi nel settore fashion?
La domanda potrebbe apparire superflua poiché i relativi marchi sono – quasi sempre – oggetto di registrazione da parte dei legittimi titolari. In realtà, la risposta non è così scontata come non è la relativa tutela che ne consegue. Ad ogni modo, per rispondere alla domanda, appare opportuna qualche premessa.
Al momento del deposito di una domanda di marchio, il richiedente è tenuto ad indicare le classi di prodotti e/o dei servizi per le quali desidera ottenere la protezione, tra quelle presenti nella Classificazione di Nizza, di cui al relativo accordo del 1957 (giunta oggi all’undicesima edizione con l’aggiornamento in vigore dal 1° gennaio 2020). Si tratta di una convenzione internazionale, suddivisa in 45 classi, di cui 34 di prodotti e 11 di servizi, all’interno delle quali è possibile rinvenire qualunque settore di interesse. Il sistema offre l’indubbio vantaggio di avere un unico parametro valido, quasi a livello mondiale, per delineare quali siano i beni o servizi sui quali il marchio può essere apposto in via esclusiva, in modo da evitare che terzi possano utilizzarlo (rectius, contraffarlo).
Ma perché tutto questo, ci si potrebbe domandare; non sarebbe molto più semplice se, ad ogni soggetto interessato, fosse concessa la possibilità di registrare il proprio marchio per qualunque prodotto o servizio? Il motivo è presto detto: per quanto possa essere fervida l’immaginazione umana, la ratio sottesa al sistema è quella di evitare che l’uso di un determinato segno – spesso non troppo distante visivamente, foneticamente e concettualmente dal prodotto o servizio per il quale viene utilizzato – sia appannaggio esclusivo di coloro che l’hanno registrato e che magari non hanno neppure necessità di utilizzarlo in settori diversi da quelli in cui operano.
Non a caso, decorso il termine di cinque anni decorrenti dalla data di deposito della domanda di registrazione, il titolare del marchio può essere chiamato a dover dimostrarne il c.d. uso “genuino” (con ciò indicando la necessità di un utilizzo vero, non solo formale) a pena di subire, qualora la prova fallisca, la perdita della titolarità del segno a seguito della dichiarazione di decadenza per non uso (ai sensi dell’art. 24 c.p.i. per l’Italia e dell’art. 58 del R.M.U.E per quanto concerne l’Unione Europea).
A ciò si aggiunga che il costo di registrazione del marchio (e, quindi, di rinnovo) aumenta con l’ampliamento delle classi di protezione e questo, soprattutto per chi deve tutelare il proprio marchio in diverse parti del mondo, rappresenta un parametro da considerare.
Il perseguimento dell’interesse sopra accennato (evitare un monopolio del segno su ogni settore) porta con sé l’ulteriore vantaggio di limitare, per quanto possibile, l’estendersi, nei registri di tutto il mondo, del fenomeno del c.d. “cimitero dei marchi”: segni registrati e mai adoperati – se non per poche classi – che, in quanto registrati dal titolare, non possono essere utilizzati da terzi, nonostante, appunto, al titolare non servano.
Stante quanto sopra, al fine di determinare l’ambito di protezione del marchio, è essenziale che l’indicazione delle classi, al momento del deposito della domanda di registrazione, sia estremamente corretta, tenendo bene a mente che dopo averla specificata in fase di deposito, non è possibile né modificarla né aggiungerne una nuova.
Ma vi è di più: a seguito del leading case “IP Translator” (Sentenza della Corte di Giustizia UE del 19 giugno 2012, C-307/10), il richiedente è tenuto ad individuare, all’interno di ciascuna classe, i singoli beni o servizi per i quali invoca la protezione, in modo da delimitare correttamente la tutela del marchio. E, come rilevato poc’anzi, avrebbe poco senso ricomprendere tutti i beni o servizi presenti nelle singole classi, posto che la tutela, decorsi i cinque anni, viene accordata solo per i beni o servizi per i quali il marchio viene effettivamente utilizzato.
L’individuazione delle classi di protezione serve anche delineare il perimetro della tutela per la maggior parte dei marchi. Ai sensi dell’articolo all’art. 20 c.p.i, infatti, il titolare del marchio ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, l’uso di un segno:
a) identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato;
b) identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell’identità o somiglianza fra i segni e dell’identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni.
Analoghe disposizioni si rinvengono nell’art. 9, n. 2 lettere a) e b) nel Regolamento (UE) 2017/1001 sul Marchio dell’Unione Europea.
Le suddette ipotesi concernono il conflitto tra due segni che siano identici per prodotti o servizi identici (sub a) – cosiddetta doppia identità – oppure tra due marchi che siano identici o simili per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell’identità o somiglianza fra i segni e dell’identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico (sub b).
Posto che per “affinità” si intende una similarità merceologica tra i prodotti o i servizi oppure un collegamento tra i bisogni che i prodotti o i servizi intendono soddisfare, il primo parametro che viene preso in considerazione è proprio la classe di registrazione (benché, tecnicamente, si tratti di un parametro meramente amministrativo).
Orbene, tenendo in considerazione quanto sopra esposto, appare inverosimile che le case di moda possano aver ipotizzato, in sede di registrazione di marchio, di ricomprendere la classe 10, normalmente richiamata, tra l’altro, per identificare “maschere utilizzate dal personale medico”.
Come fare?
Soccorre in proposito la lettera c) dell’art. 20 c.p.i (e dell’art. 9, n. 2 del R.M.U.E.) ai sensi della quale il titolare del marchio può vietare a terzi l’uso di un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini “se il marchio registrato goda nello stato di rinomanza e se l’uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi”.
In sostanza, grazie a tali norme, si ha un’estensione della tutela per prodotti non affini a quelli oggetto di registrazione e, dunque, a beni o servizi che sono al di fuori dei principali settori di riferimento del titolare della registrazione. Naturalmente, maggiore è la notorietà del marchio, maggiore sarà l’estensione della tutela sino a ricomprendere ambiti merceologici sempre meno affini.
Si parla infatti in questo caso di tutela “ultra-merceologica” – che prescinde dal rischio di confusione di cui all’ipotesi sub lettera b) – invocabile allorché il titolare sia in grado di provare che il proprio segno gode di rinomanza, sia a livello territoriale che con riferimento al pubblico interessato.
Tra i parametri per determinare il grado di notorietà di un marchio, rientrano la quota di mercato, l’intensità, l’ambito geografico e la durata del suo uso, nonché gli investimenti realizzati dall’impresa per promuoverlo.
Sarà quindi necessario reperire materiale utile a dimostrare sia l’alto grado di diffusione, partendo dalle domande di registrazione ottenute nei vari Paesi, sia il livello di prestigio consolidato dal brand sul mercato. Estremamente utile inoltre, per non dire essenziale, è la produzione di un’indagine demoscopica volta a confermare l’elevato grado di conoscenza del marchio nel pubblico.
Peraltro, come richiamato dalla suddetta norma, la tutela è concessa se l’uso del segno consente di trarre un indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio, o se tale uso reca pregiudizio al carattere distintivo o alla rinomanza del marchio stesso.
Ed ecco che l’indebito vantaggio ricorre, come nel caso della vendita di mascherine griffate, quando il terzo aggancia parassitariamente il proprio marchio alla notorietà o alla distintività del marchio rinomato, traendone benefici di varia natura.