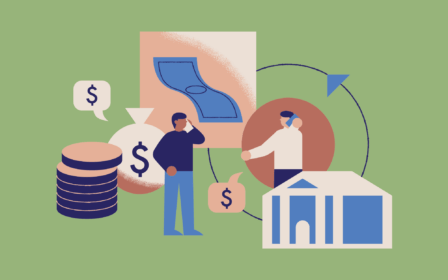
Sfratto per morosità e affitto di azienda: la parola alla Corte di Cassazione
La c.d. Riforma Cartabia ha espressamente esteso l’applicabilità della procedura di sfratto per finita locazione ai contratti di affitto d’azienda, lasciando …
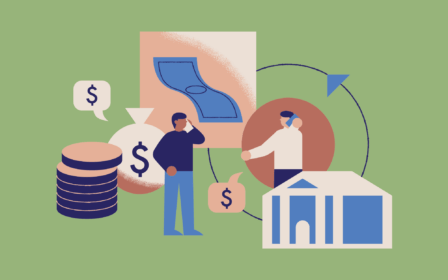
La c.d. Riforma Cartabia ha espressamente esteso l’applicabilità della procedura di sfratto per finita locazione ai contratti di affitto d’azienda, lasciando …
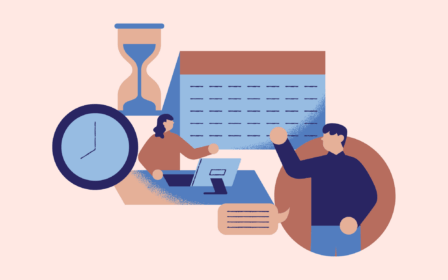
La cronaca delle ultime settimane conferma la preoccupante espansione ed il radicamento, nella filiera dell’appalto, del “caporalato”, sistema di gestione illecita del personale, spesso non tracciato dall’imprenditore a capo della filiera anche se è il soggetto che corre i rischi maggiori. E rivela come sia cambiato l’approccio al fenomeno da parte della magistratura e degli organi ispettivi.

La nuova direttiva qualifica espressamente le asserzioni ambientali ingannevoli come pratiche commerciali vietate, dando in questo modo seguito al percorso avviato dalle autorità indipendenti e dalla giurisprudenza in materia di greenwashing. L’opera non è ancora completata, ma prima dell’entrata in vigore sono attesi ulterori passi in avanti per migliorare ulterioremente la tutela dei consumatori contro tali pratiche decettive.
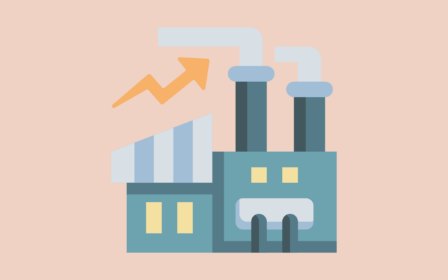
Una recente decisione della Cassazione sugli accordi di aumento del canone offre lo spunto per alcune considerazioni in merito all’opportunità di rinnovamento della legge sulle locazioni commerciali e sui possibili profili di miglioramento.

Anche quest’anno il nostro studio si conferma nella classifica di The Legal 500 Europe, Middle East & Africa 2024 come studio legale leader …

Se siete appassionati di Maratona di Milano, come lo siamo noi qui a COCUZZA, probabilmente troverete interessanti alcuni consigli motivazionali che …

La sentenza n. 7/2024 mette fine ad ogni discussione circa la legittimità costituzionale del Jobs Act: le disposizioni principali (esclusione della reintegra e indennità risarcitoria) risultano legittime e, pertanto, la reintegra nel posto di lavoro sembrerebbe ormai un rimedio marginale.
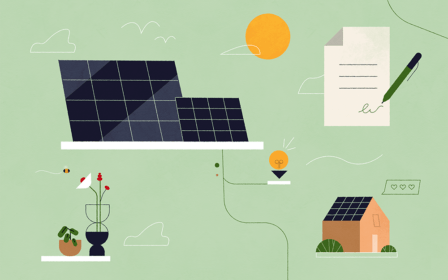
Il 14 febbraio 2024 è entrato in vigore il decreto del Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica n. 436 del 22 dicembre 2023, volto ad incentivare la realizzazione e la diffusione di sistemi agrivoltaici innovativi di natura sperimentale.

Nella nostra newsletter del novembre scorso avevamo raccontato i vantaggi e il funzionamento delle Comunità Energetiche Rinnovabili, nell’attesa che venisse concluso l’iter legislativo in corso. A distanza di qualche mese, torniamo sul tema, dal momento che è stato finalmente approvato il decreto. Vediamo nel dettaglio quali sono le novità.

Riportiamo alcuni spunti di riflessione relativi alla gestione dei rapporti tra le aziende e gli influencer alla luce di alcuni recenti interventi di due Autorità di Vigilanza.