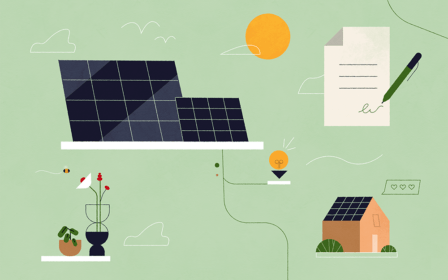La Corte costituzionale legittima la disciplina dei licenziamenti collettivi prevista dal Jobs Act
La sentenza n. 7/2024 mette fine ad ogni discussione circa la legittimità costituzionale del Jobs Act: le disposizioni principali (esclusione della reintegra e indennità risarcitoria) risultano legittime e, pertanto, la reintegra nel posto di lavoro sembrerebbe ormai un rimedio marginale.